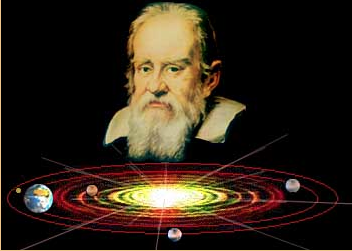Per il nostro Paese il vero secolo buio, l’epoca della tirannia sul pensiero scientifico e del corto circuito della cultura libera fu il ‘600, ad esiti del Concilio di Trento (1545-1563) ampiamente consolidati e operatività dei gesuiti e del tribunale dell’Inquisizione in piena efficienza e pervasività. Le vicende relative all’abiura che Galileo Galilei pronunciò dopo la sentenza di condanna pronunciata nel convento domenicano di S. Maria della Minerva dal Tribunale nell’anno 1633 sono note; tuttavia, continua a fare un triste effetto di repulsa il contenuto e i toni di quell’abiura (presumibilmente scritta sotto dettatura dei giudici). Vediamo di seguito:
Galileo Galilei era allora un uomo di 70 anni, famoso in tutta Europa per aver “inventato” la scienza, non solo e non tanto per alcune scoperte fondamentali (sua l’invenzione del telescopio, la teoria del moto pendolare, la teoria sulla velocità di caduta degli oggetti , la Via lattea come immenso agglomerato di stelle), ma soprattutto per aver applicato e illustrato i principi del metodo scientifico nell’osservazione della natura e nella comprensione delle sue leggi fisiche. In contatto epistolare con Giovanni Keplero, altro grande astronomo copernicano e matematico , Galilei sosteneva – con forza e a volte con dileggio del modo di ragionare “aristotelico” dei gesuiti – la teoria di Niccolò Copernico (vissuto circa un secolo prima dal 1473 al 1543) secondo la quale non era il sole a girare intorno alla Terra, ma al contrario é quest’ultima ad essere parte, con altri pianeti, di un sistema con al centro il Sole: una teoria del genere metteva in crisi un sistema di pensiero millenario che concepiva la Terra come centro del mondo (e di conseguenza l’Uomo come centro di tutto). Ma la critica al pensiero cattolico-tridentino allora dominante si spingeva ben più oltre: Galileo contestava la lettura di Aristotele compiuta dai gesuiti e dal pensiero ufficiale cattolico, secondo la quale il pensiero razionale astratto è in grado di interpretare i fenomeni della natura, in un intreccio di fisica e metafisica; egli spiegava, invece, che c’è netta distinzione fra il piano della fede e l’osservazione del “gran libro della natura“: sia la Bibbia che il libro della natura sono stati scritti da Dio, ma per quanto riguarda il primo Dio si è rivelato agli uomini in termini che si adattano alla natura umana; per quanto riguarda il secondo, invece, la natura viene indagata mediante la scienza. Cioè, non si può confondere la fede religiosa con la scienza. In questa concezione dell’autonomia della ragione rispetto alla fede possiamo vedere chiari prodromi del pensiero successivo di Blaise Pascal ed Emanuele Kant.
Un potere assoluto e spietato mise a tacere l’enorme sorgente di sapienza rappresentata da Galileo Galilei e interdisse con la messa all’indice dei suoi libri la possibilità di conoscere e studiare il suo pensiero; lo stesso trattamento spietato fu riservato 30 anni prima al filosofo Giordano Bruno, condannato al rogo e a Tommaso Campanella, che subì quattro processi per eresia, dopodiché terminò i suoi giorni alla corte di Luigi XIII di Francia, rispettato e riconosciuto come uomo di grande intelletto.
Ben diverso trattamento ebbe il pensiero scientifico in Francia, in Inghilterra, in Germania e perfino nell’Impero asburgico: qui gli aneliti di libertà del pensiero, complice l’espansione della borghesia mercantile, prevalsero e costituirono il fattore determinante per lo slancio scientifico e tecnologico che da quel momento caratterizzò la storia del mondo. L’Italia della controriforma, invece, entrava in un cono d’ombra da cui forse ancora oggi non siamo completamente usciti.
Ma ciò che più qui importa è comprendere se l’abiura di Galileo, la rinuncia a sostenere le proprie idee (pena la morte) non sia diventato un tratto distintivo di una certa volubilità e viltà intellettuale nostrana che non esita mai e ritrarsi e a prostrarsi di fronte al pensiero del potente di turno; che non sia il prodromo antico di una debolezza morale ed etica che giustifica, ancora oggi agli occhi di molti, i voltagabbana, le piroette del pensiero, l’affermare oggi idee completamente opposte e incomunicanti rispetto a quelle di un passato anche recente.
Ma non pare a noi che sia questa la vera questione: Galileo era un uomo anziano e forse fu saggio nell’abiurare: l’Inquisizione non avrebbe esitato certo a mandarlo a morte se avesse confermato il suo pensiero. Nè si può dire che la pratica del coraggio sia da quel momento svanita fra i pensatori e intellettuali italiani: basti pensare alle figure di Piero Gobetti, Giovanni Amendola, Giacomo Matteotti e Antonio Gramsci, che pagarono con la vita la coerente affermazione delle proprie idee.
Invece, a parere di chi scrive, la vicenda di Galileo indusse un male della mente molto più sottile e pernicioso: l’idea che sia inutile esporre un’idea contraria al pensiero del potente o dei potenti di turno: che sia inutile perché la loro superiore posizione di forza rende inefficace, ridicolizza, annienta qualunque dissenso o pensiero diverso; tanto che diventa inutile la testimonianza di quel pensiero. Quindi la questione del coraggio si muta in problema di fiducia nella validità e utilità del proprio pensiero e della propria testimonianza. Questa forse fu la conseguenza più perniciosa dell’abiura di Galileo: essa penetrò nelle menti di molti suoi discendenti su, su fino ai nostri giorni, quando ancora incontra massicci consensi. Crediamo abbastanza facile comprenderne le ragioni: c’era chi, un secolo prima di Galilei, aveva miseramente chiuso il ciclo glorioso del pensiero italiano teorizzando i vantaggi dell’accomodamento coi potenti: Francesco Guicciardini nei suoi “Ricordi politici e civili” (che differentemente da Galilei volle che non fossero mai pubblicati in vita per timore di indispettire Papi o Granduchi) affermò testualmente: “n. 28. Io non so a chi dispiaccia piú che a me la ambizione, la avarizia e le mollizie de’ preti; sí perché ognuno di questi vizi in sé è odioso, sí perché ciascuno e tutti insieme si convengono poco a chi fa professione di vita dipendente da Dio; e ancora perché sono vizi sí contrari che non possono stare insieme se non in uno subietto molto strano. Nondimeno el grado che ho avuto con piú pontefici, m’ha necessitato a amare per el particulare mio la grandezza loro; e se non fussi questo rispetto, avrei amato Martino Luther quanto me medesimo...”(vedi qui meglio). Questa mollezza, disincanto e vigliaccheria del pensiero interpretano molto bene una parte ancora immanente del pensiero etico nostrano.
Ma è proprio la vicenda del Galileo a dimostrarci il contrario: le sue idee – soffocate nell’angusto contesto nazionale – varcarono i confini e divennero seme e radice del metodo scientifico moderno: quindi furono “utili”, servirono a qualcosa, resistettero al dominio della forza e del conformismo, costituirono una testimonianza preziosa e insostituibile. Quanto a dire che, nella questione del “coraggio” delle proprie idee, costituisce elemento fortificante dello stesso la “fiducia” nel valore della propria testimonianza, quando ragione, fede e buon senso ci regalano i frutti “del giusto e del vero”. Come per i Padri Pellegrini del Mayflower.
Giuseppe Beato